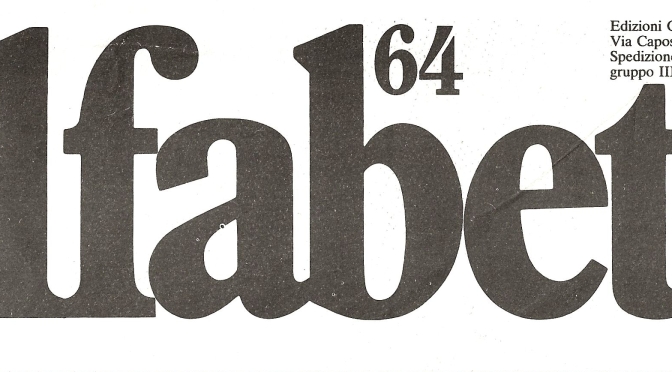“Critica integrale” compie due anni. Con 174 articoli pubblicati ha assolto pienamente lo scopo, che era quello di tener in attività le sinapsi del sottoscritto. Quanto alla ricezione, si sa che non è calcolabile e che il numero dei visitatori e delle visualizzazioni non conta (uno entra per curiosità pochissimi secondi, un altro per errore, un altro legge ma non condivide, un follower lo fa sperando nel contraccambio, eccetera ecceterone). Comunque, per festeggiare il secondo giro di boa, spero di far cosa gradita ripubblicando un vecchio articolo, mai più ripreso. Si tratta del pezzo uscito su “Alfabeta” 64 (settembre 1984) nella fase di preparazione del convegno sul “Senso della letteratura” che si è svolto a Palermo di lì a poco. Un convegno davvero importante i cui atti sarebbero da ripubblicare per intero e dimostrerebbero una buone dose di attualità.
L’interruzione
Anche se la letteratura, nella sua forma scritta, è pronta a sopportare una fruizione interrotta — sguardo che si arresta pensieroso sulla riga oscura del libro, o che erra distratto altrove; mano che richiude il volume con un segno tra le pagine, o insoddisfatta lo squinterna e, al limite, lo getta lontano —, tuttavia il testo tende a costringere il proprio lettore in un insieme omogeneo, soprattutto quando punta su un coinvolgimento di tipo emotivo. Diciamo che il testo ci prende, allorché il «senso della letteratura» occupa per intero la sensibilità e la possiede mediante l’esca delle sue suggestioni. In questa attrattiva, l’interruzione è intoppo inopinato, inconveniente frustrante, mala creanza; è, davvero, l’estraneo che guasta l’atmosfera del consentimento.
Diversamente, se il testo propende a fornire stimoli alla riflessione, l’interrompersi diventa un comportamento necessario e connaturato alla sua stessa comunicazione. Infatti, mentre l’emozione
sempre bruciata nell’istante, e quindi è sbilanciata in avanti a mantenere l’intensità, la riflessione è, al contrario, sempre rivolta all’indietro, perché solo uno sguardo retrospettivo può stabilire relazioni e collegamenti. La riflessione sul testo è un percorso non lineare e teso, ma accidentato e frastagliato, dove, non che permessi, sono richiesti l’inversione del senso di marcia, il ritorno a più riprese, la pausa. Alla rapidità dell’emozione, si sostituisce una rimuginante e circonvoluta lentezza.
Che poi anche il cogitare meditabondo prediliga concentrazione e raccoglimento, non muta il problema; si tratta di considerare l’interruzione come punto contraddittorio di qualsiasi apparato rituale che difenda la propria aura mediante la chiusura verso l’esterno. Per quanto riguarda la letteratura, più che sulla continuità dell’esecuzione (precaria: a meno di non abbandonare l’oggetto-libro per il concerto vocale), è possibile calcare sulle prerogative rappresentative o evocative di un organismo separato dal mondo, e proprio perciò equivalente di esso. Quanto più il mondo esterno è escluso, tenuto a distanza, tanto più il microcosmo varrà per la totalità e ne sarà il sostituto. Il testo come metafora del mondo: si potrebbe dire, con Lotman, che grazie alla dislocazione dei limiti (la cornice che separa il testo dal non-testo) qualsiasi opera assume la fisionomia di «modello finito di un mondo infinito».
Eppure, è sufficiente allargare lo sguardo perché lo stesso fenomeno testuale appaia come parte marginale, contigua ad altre produzioni: intratterrebbe allora un nesso metonimico, nel riferimento al mondo. Per rendere conto di questa duplicità di metafora e metonimia del mondo, il testo deve superare i limiti, uscire fuori di sé: a ciò potrebbe servirsi anche dell’interruzione, se trasferita dal consumo alla sfera della costruzione della scrittura.
Direi che il passaggio è distintivo della ricerca letteraria moderna: non solo al modo del frammento, del non-finito con cui il testo enuncia la propria parzialità e lacunosità rispetto a un continuum ormai irrecuperabile; e non solo con l’esplosione del grido e della opacità somatica nelle maglie prevedibili della comunicazione convenzionale. Si tratta, indubbiamente, di incompostezza; preferirei però parlare di interferenza tra convenzioni e ipotesi espressive in contesa su di un terreno dove le dissonanze linguistiche (e culturali) non vengono più occultate, ma riconosciute e messe in gioco. Al-meno quanto basta a sospendere lo scontato senso comune della letteratura, su cui si basano le risposte immediatamente emotive.
Riprendo l’idea di una interruzione nel testo da alcuni cenni di Walter Benjamin, teorico per altro interessato all’interruzione anche sul piano più generale della filosofia della storia. Nel saggio sulle Affinità elettive di Goethe (riproposto qualche tempo fa nel volume di scritti 1919-1922, Il concetto di critica nel romanticismo tedesco, Torino, Einaudi, 1982), allargando il discorso dal testo in esame, Benjamin scorge la necessità di un «arresto» che costituisca il controcanto della bellezza e dell’armonia prodotte dall’opera d’arte.
Questo qualcosa che «interrompe» è da lui definito das Ausdruckslose, il «privo di espressione» — la precedente traduzione dicendo l’«inespresso» ne faceva qualcosa di implicito ed assente, mentre invece è una funzione esplicita. Nell’interruzione, secondo Benjamin, «il bello deve render conto di se stesso»; più precisamente, il «privo di espressione è la potenza critica» o «la potenza superiore del vero» che spezza «quello che resta, in ogni bella apparenza, come eredità del caos: la totalità falsa, aberrante — la totalità assoluta. Esso solo compie l’opera riducendola a un ‘pezzo’, a un frammento del vero mondo, al torso di un simbolo».
Chi volesse servirsi, in tutta la sua problematica, di questa ipotesi benjaminiana potrà ritrovare l’intero brano, assai ridotto nella mia citazione (è alle pp. 233-35 de II concetto di critica; nella ed. in An¬gelus novus, Torino, Einaudi, 1962, si trova alle pp. 211-13). Per ora e qui, va segnalato il contrasto, nell’interruzione, tra totalità e frammento (che sarà poi nella nozione benjaminiana di allegoria), e va notata l’apertura di uno spazio critico interno all’opera e determinante per il suo valore. S’intravede la possibilità di una posizione duplice e straniante.
Questo modo consente di ricollegare il «senso della letteratura» al contesto culturale senza annullare l’apporto e le peculiarità specifiche. Inoltre, il doppio punto di vista lavora, da un lato, a inserire una nota disarmonica (una asimmetria), che deforma le regole convenzionali della letterarietà, e le assoggetta al mutamento storico. Dall’altro lato, e nello stesso tempo, rende problematica la fantasmatizzazione, il sistema di modelli (comportamentali, spazio-temporali, ecc.) connessi al serbatoio tematico della letteratura.
Risulta opportuno operare insieme su entrambi i versanti che in realtà sono le facce di una stessa medaglia. Altrimenti si finisce in braccio o a una letteratura autosufficiente che si riproduce per partenogenesi (senza toccare le radici, ossia senza mettere in questione il ceto corporativo); o a una letteratura al di là e al di sopra dei linguaggi dell’uso, in quanto tale contestativa dei logori significati quotidiani, con ciò fuori della cultura e della lingua collettiva per privilegio poetico.
Dal canto suo l’interruzione, intesa come un singolo procedimento, sarebbe facilmente isolata e riassorbita; dobbiamo piuttosto considerarla come uno dei lati con cui si presenta la scrittura «in cerca di nuovo statuto». È solo uno dei lati possibili. Vale, provvisoriamente, da indicazione alternativa nei confronti delle varie forme di recupero di valori letterari sicuri: che altro è, in fondo, il privilegiamento dell’emozione, se non un fermarsi al primo dato di fatto che si incontra, facendone un incontestabile e comodo metro valutativo? Si va sul sicuro: con una gamma di offerte, dal classico al moderno, al postmoderno, ma in ogni caso senza spingere il riciclaggio oltre i limiti dell’accettabile.
La narrativa, con l’occhio ai successi del triviale, chiude agli esperimenti, lasciando all’autore, al massimo, l’ammiccamento indicante consapevolezza nel servirsi di trucchi accattivanti; la poesia, dopo la febbre giovanile dell’oralità, sembra ora voler attestare la ricomposizione del proprio valore positivo in una ritrovata funzione redentrice e sublimante. Le eccezioni a questo blocco sono presenti e attive, ma troppo spesso disperse — di qui l’importanza di estendere le occasioni di confronto e di dibattito sul senso della letteratura.
Per paradosso, l’omologazione pretende di agire nel nome dei sacri diritti de lettore a una degustazione indisturbata; mentre è con l’allontanamento dell’interruzione che il destinatario viene svalutato, confinato com’è sullo sfondo di una ricezione passiva e muta. La ricerca di un rapporto intellettuale interattivo richiede che la scrittura accetti il destino del mondo profano e materiale: l’eterogeneo e il discontinuo, la molteplicità dei codici e delle prospettive , la violazione dei confini. Un oggetto manipolabile: da usare.
(“Alfabeta” n. 64, settembre 1984, p. 17)
03/11/2021